La natalità in Italia tocca nel 2024 un nuovo minimo storico: appena 369.944 nati, con una riduzione del 2,6% rispetto al 2023, pari a quasi diecimila bambini in meno. Il tasso di natalità scende a 6,3 per mille residenti, ben al di sotto del 9,7‰ registrato nel 2008, quando il Paese contava oltre 576mila nuovi nati.
Il calo, spiega l’ISTAT, è un fenomeno strutturale che perdura da oltre quindici anni e che ha comportato, dal 2008 a oggi, una perdita complessiva di oltre 200mila nascite (-35,8%). A incidere è non solo la ridotta propensione ad avere figli — con una fecondità media di 1,18 figli per donna, la più bassa mai rilevata — ma anche il progressivo assottigliarsi delle generazioni nate negli anni Settanta, quando il tasso di fecondità scese sotto la soglia di sostituzione.
Fattori demografici e territoriali: il Mezzogiorno arretra di più
La denatalità riguarda tutto il territorio nazionale, ma con intensità differenziate. Nel Mezzogiorno la contrazione è più marcata (-4,3% per i primogeniti), mentre nel Nord e nel Centro la flessione si ferma rispettivamente a -1,8% e -2%.
Le condizioni economiche e sociali restano determinanti: precarietà lavorativa, difficoltà di accesso alla casa e posticipo della formazione familiare incidono sulla decisione di avere figli.
La riduzione interessa soprattutto le coppie italiane, che rappresentano oltre i tre quarti delle nascite totali (78,2%): nel 2024 i nati da genitori entrambi italiani calano del 3,3%, mentre quelli con almeno un genitore straniero restano sostanzialmente stabili (21,8% del totale). Nel Nord, dove la presenza straniera è più radicata, quasi un nato su tre ha almeno un genitore non italiano. Le cittadinanze più rappresentate tra i nuovi nati sono rumena, marocchina e albanese.
Denatalità e futuro: una sfida per istituzioni e territori
I dati provvisori del 2025 confermano il trend negativo: tra gennaio e luglio le nascite sono scese del 6,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’evidenza statistica pone una questione cruciale per il sistema-Paese: senza un ricambio generazionale sostenuto, saranno sempre più rilevanti gli effetti sulla sostenibilità previdenziale, sul mercato del lavoro e sulla distribuzione territoriale della popolazione.
Per la Pubblica Amministrazione e gli Enti locali si impone la necessità di integrare la dimensione demografica nella programmazione economica e sociale, potenziando politiche per la conciliazione lavoro-famiglia, i servizi per l’infanzia e il sostegno all’abitare.
L’emergenza demografica, sottolinea l’ISTAT, non è più un fenomeno congiunturale ma una priorità strutturale: affrontarla significa garantire coesione, crescita e continuità al sistema sociale ed economico italiano.
Fecondità in Italia ai minimi storici
Nel 2024 il numero medio di figli per donna scende a 1,18, inferiore al minimo storico del 1995 (1,19) e lontano dal massimo del nuovo millennio (1,44 nel 2010). La riduzione riguarda sia le donne italiane (1,11 figli per donna, in calo dal 1,14 del 2023) sia le donne straniere (1,79, in diminuzione dal 1,82 del 2023).
Il calo della fecondità è generalizzato sul territorio nazionale: il Centro registra la fecondità più bassa (1,11), il Nord 1,19 e il Mezzogiorno 1,20. Tra le regioni, la provincia autonoma di Bolzano/Bozen mantiene il valore più alto (1,51), mentre la Sardegna rimane la più bassa (0,91).
Nei primi sette mesi del 2025, le stime indicano un ulteriore calo a 1,13 figli per donna, con il Centro a 1,04, il Nord a 1,15 e il Mezzogiorno a 1,16. Solo alcune regioni mostrano una lieve ripresa, tra cui le province autonome di Bolzano e Trento, Valle d’Aosta e Basilicata.
L’analisi per coorti di nascita evidenzia un trend decrescente costante: le donne nate nel 1947 hanno avuto in media 2,01 figli, mentre quelle del 1975, che nel 2024 hanno completato il periodo riproduttivo, 1,44. Parallelamente, la quota di donne senza figli è salita dal 10% per la generazione del 1947 al 23% per quella del 1975, indicando sia difficoltà oggettive legate alla genitorialità sia scelte di vita alternative alla maternità.
Diffusione crescente dei nati con doppio cognome
Nel 2024, il 6,7% dei neonati in Italia ha ricevuto sia il cognome paterno sia quello materno, registrando un aumento di 4,3 punti percentuali rispetto al 2020. Il fenomeno è più diffuso nel Centro-Nord (8,6% nel Nord, 8,3% nel Centro) e meno nel Mezzogiorno (6,4%).
Il doppio cognome è più frequente tra i primogeniti (9,2%) rispetto ai secondi figli (4,7%) o ai figli di ordine superiore (3,0%), riflettendo la maggiore propensione dei genitori dei primi nati ad adottare la novità legislativa introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016.
Tra le coppie coniugate, la quota di doppi cognomi è più bassa (5,3%), mentre sale all’8,5% tra le coppie non coniugate. La scelta dipende anche dalla cittadinanza dei genitori: la percentuale più alta si registra nelle coppie miste con madre italiana e padre straniero (14,1%), seguite da coppie con madre straniera e padre italiano (7,1%) e coppie italiane (6,6%). Le coppie con entrambi i genitori stranieri attribuiscono il doppio cognome solo nel 5,2% dei casi.
Un fenomeno rilevante riguarda i genitori di cittadinanza latina (Spagna, Portogallo, America Latina), per i quali il doppio cognome è consuetudine: tra le coppie latine entrambi i genitori, l’89,3% dei figli riceve il doppio cognome; se solo uno dei genitori è latino, la percentuale scende al 33,4%.
In sintesi, il doppio cognome continua a diffondersi, trainato principalmente dai primogeniti, dalle coppie miste e dalle tradizioni culturali dei genitori stranieri, mostrando come la normativa del 2016 sia progressivamente recepita, pur con differenze regionali e sociali.
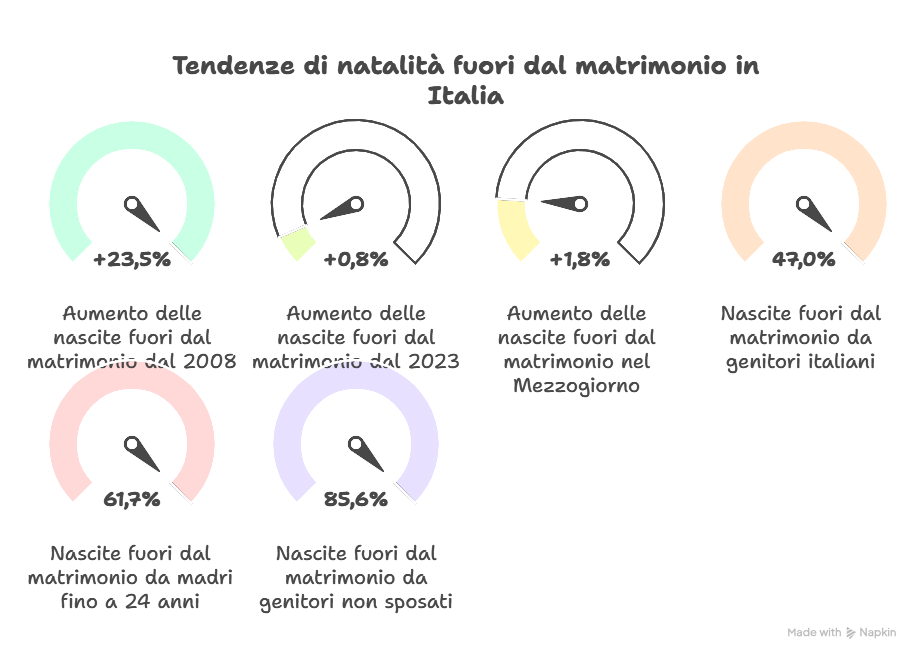
Nomi più scelti nel 2024: Leonardo e Sofia dominano le classifiche
Nel 2024, Leonardo conferma il primato tra i nomi maschili a livello nazionale, seguito da Edoardo e Tommaso. Francesco, già fuori dal podio nel 2023, scende al sesto posto. Tra le femmine, la classifica delle prime cinque posizioni resta invariata rispetto all’anno precedente: Sofia al primo posto, seguita da Aurora, Ginevra, Vittoria e Giulia.
A livello regionale, Leonardo domina in quasi tutto il Nord e il Centro, con alcune eccezioni come la Provincia autonoma di Bolzano/Bozen (Noah) e la Valle d’Aosta (Edoardo e Tommaso). Al Sud, Leonardo è primo solo in Abruzzo, mentre Francesco, Antonio e altri nomi locali mantengono il primato in alcune regioni. Tra le bambine, Sofia prevale nel Centro-Nord, ma al Sud il panorama è più variegato: Aurora, Giulia, Vittoria e Ginevra condividono il primato a seconda della regione.
I nati stranieri residenti in Italia mostrano preferenze diverse: i maschi si chiamano principalmente Rayan, Adam, Amir, Liam, ma anche Matteo e Leonardo, mentre le femmine seguono le stesse tendenze italiane, con Sofia al primo posto, seguita da Sara e Amira.
Le scelte dei genitori stranieri riflettono le tradizioni culturali e la volontà di integrarsi:
– Romeni preferiscono nomi diffusi in Italia: Matteo, Luca, Leonardo per i maschi; Sofia, Melissa, Eva Maria per le femmine.
– Albanesi scelgono più spesso nomi del Paese d’origine per i maschi (Amar, Liam, Aron), mentre le femmine prendono nomi italiani (Luna, Emily, Amelia).
– Marocchini e Bangladeshi mantengono nomi tradizionali dei loro paesi: Adam, Amir, Rayan e Amira, Sara, Nour per il Marocco; Abdullah, Ayan, Anas e Anabia, Sara, Inaya per il Bangladesh.
In sintesi, la tendenza nazionale conferma Leonardo e Sofia come nomi più popolari, con differenze regionali e influenze culturali evidenti tra i neonati stranieri, che combinano tradizione e integrazione nel contesto italiano.









Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento